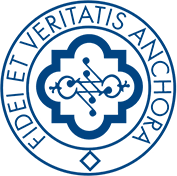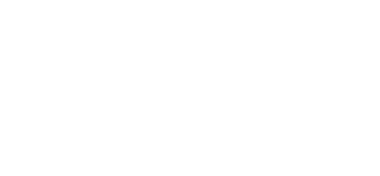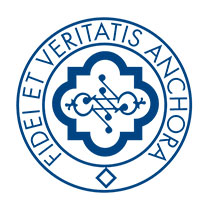CERCA
Studio n. 40-2025/P L’AGIBILITÀ DOPO IL DECRETO CD. SALVA CASA
Autore:
Giuseppe Trapani
10/07/2025
La disciplina dell’agibilità ha subito alcune modifiche di particolare incisività: il Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 ed il d. l. 29 maggio 2024 n. 69 (c.d. “salva casa”) convertito nella legge 24 luglio 2024 n. 105 (in G.U. n. 175 del 27-07-2024), che hanno in modo radicale inciso sul dettato dell’art. 24 TUE. La modulazione dell’obbligo della segnalazione certificata quale strumento tecnico per l’agibilità gioca quindi un ruolo importante negli schemi convenzionali, con la previsione in ipotesi di inottemperanza di una specifica sanzione amministrativa. Essa va richiesta per i seguenti interventi: (a) nuove costruzioni; (b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; (c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto corredata dalla documentazione esattamente prevista dalla norma.
Se l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano del rischio della risolubilità del contratto e quindi dell’esigenza alla stabilità delle contrattazioni.
Studio n.15-2025/CTS I COMITATI DEL CODICE CIVILE E DEL TERZO SETTORE
Autore:
Daniela Boggiali e Rocco Guglielmo
09/07/2025
Lo studio analizza le caratteristiche e la disciplina dei comitati, sia rispetto alle norme del codice civile, sia con riferimento all’eventualità che questi assumano la qualifica di ente del terzo settore. In particolare, si esamina la possibilità che i comitati possano acquistare la personalità giuridica sia tramite iscrizione nei registri delle persone giuridiche, sia tramite iscrizione al RUNTS.
Studio n. 226-2024/P ACCERTAMENTI DI CONFORMITÀ: ARTT. 36 E 36 BIS TUE E ATTIVITÀ NOTARILE
Autore:
Marcello Claudio Lupetti e Cristina Lomonaco
08/07/2025
Lo studio esamina gli articoli 36 e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 sui procedimenti di sanatoria cd. “a regime” dopo le modifiche introdotte dal decreto Salva Casa. Il contributo esamina, in particolare la nozione di accertamento di conformità, la sua ratio, i presupposti, e il contenuto del provvedimento di sanatoria. Le modifiche normative agevolano il lavoro del notaio distinguendo le ipotesi di assenza di titolo e di totale difformità (disciplinate dall’art. 36) da quelle di parziale difformità e di variazioni essenziali (disciplinate dall’art. 36 bis). Viene analizzata la nuova conformità “asimmetrica”, con particolare attenzione alle menzioni urbanistiche alla luce anche della recente posizione delle Sezioni Unite.
Studio n. 225-2024/P Lo stato legittimo degli immobili dopo il c.d. decreto Salva Casa
Autore:
Giuseppe Trapani
24/06/2025
Lo stato legittimo consiste nella (modulazione della) conformità alle norme vigenti del bene esistente in oggetto, la cui situazione tecnico giuridica deriva da alcuni elementi che la norma provvede ad individuare esattamente e discende essenzialmente dal titolo abilitativo che ha legittimato la edificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare o dalle altre condizioni esattamente definite dal legislatore. Lo stato legittimo può essere determinato in via alternativa sulla base: i) del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o ii) del titolo rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, (a condizione che tale titolo sia stato rilasciato all’esito di un procedimento che abbia verificato l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa) integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
La dichiarazione dello stato legittimo di un immobile – sia contenuta all’interno della dichiarazione tecnica procedimentale, sia nella relazione allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali – non esclude la sussistenza degli obblighi formali di menzione disciplinati dalla legge.
Studio n. 62-2025/P Le tolleranze costruttive ed esecutive dopo il Cd. Decreto Salva Casa
Autore:
Giuseppe Trapani
18/06/2025
Sono definite tolleranze costruttive gli scostamenti considerati lievi rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, perché rientranti nei parametri percentuali esattamente individuati dal legislatore. Viene ampliato il campo di applicazione della disposizione con un richiamo generico anche al “mancato rispetto” di “ogni altri parametro” (art. 34 bis 1 comma TUE), ma muta, invece, l’indice per la valutazione della tolleranza costruttiva: non più il 2 per cento delle misure progettuali, ma il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, con la previsione di parametri crescenti per il tempo anteriore all’entrata in vigore delle nuove norme.
Costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi a condizione che non comportino violazione alcuna della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile ed i parametri dettati al proposito dal legislatore e devono essere eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.
Non si tratta di fattispecie oggetto di disvalore da parte del legislatore il quale non solo non le considera violazioni edilizie da sanzionare ma, per converso, attraverso la loro regolazione, mira a sbloccare la situazione di stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore.
Studio n. 4/2024M – La rappresentanza in mediazione
Autore:
Paolo Forti
05/06/2025
La mediazione, strumento di ripristino della connessione dialogica interrotta tra le persone, a fini di riconciliazione, parrebbe richiedere la necessaria presenza innanzi al mediatore di tutti i confliggenti. L’ammissibilità di sostituzione dell’interessato con un terzo richiede un’attenta e cauta valutazione. Per giungere ad un risultato proficuo, l’interprete deve tener conto delle specificità della materia, nella quale si è operata una sintesi tra lo strumento metagiuridico di ricomposizione del conflitto e la norma civilistica. In coerenza con tale impostazione, lo studio ripercorre le ragioni profonde, umane e concettuali, della mediazione, e rinviene proprio in queste la legittimità delle ipotesi di sostituzione, riconoscendo spazio, ma solo con necessari aggiustamenti, anche all’istituto giuridico della rappresentanza.
Lo studio attua poi una capillare ricerca, nella giurisprudenza anteriore alla riforma Cartabia, delle tracce, in verità copiose, di analoga consapevolezza della singolarità del fenomeno; adoperandosi anche a dimostrare come, al contrario, ogni tentativo di applicazione in mediazione, passiva e non consapevole, dei principi ordinari di diritto civile sulla rappresentanza, conduca ad aporie logiche e interpretative.
La regolamentazione dei limiti della rappresentanza da parte del legislatore della Cartabia mostra chiara consapevolezza di questo lungo percorso di sintesi tra mediazione e diritto e si pone al termine dello stesso. È così agevole pervenire ad un’interpretazione soddisfacente delle nuove norme; ivi comprese quelle sulla forma della delega, introdotte dal decreto correttivo al primo testo portato dalla riforma.
Studio n. 24-2025/C – Condominio e immobile gravato da usufrutto
Autore:
Giuseppe Musolino
04/06/2025
Studio n. 3/2024M Il primo incontro di mediazione e l’obbligo di cooperare in buona fede e lealmente
Autore:
Mario Buzio
22/05/2025
Lo studio analizza le peculiarità del primo incontro di mediazione e dell’obbligo di cooperare in buona fede e lealmente, alla luce della recente “Riforma Cartabia” (D. Lgs. 10/10/2022 n. 149 e D.M. 24/10/2023 n. 150). Ripercorre dapprima l’evoluzione normativa e le diverse interpretazioni giurisprudenziali relative al primo incontro, evidenziando come la riforma abbia inteso superare la concezione di un mero “rituale informativo” per affermare la necessità di un’attività di mediazione “effettiva” fin dall’inizio. Vengono poi esaminati gli aspetti cruciali del primo incontro, tra cui la convocazione, lo svolgimento (con una durata minima di due ore), la partecipazione personale delle parti (limitando la delega a casi giustificati e richiedendo ai rappresentanti piena conoscenza dei fatti e poteri decisionali), e l’obbligo di cooperare in buona fede e lealmente sia per le parti che per i loro avvocati. Lo studio si sofferma anche sul ruolo delle interazioni ripetute che si svolgono nel procedimento di mediazione e delle tecniche di mediazione nel facilitare il raggiungimento di un accordo e in particolare esamina la mediazione secondo la teoria dei giochi. In sintesi lo studio sottolinea come la riforma Cartabia miri a valorizzare il primo incontro di mediazione come un momento sostanziale di confronto e possibile risoluzione della controversia, promuovendo una giustizia consensuale e la ricostruzione delle relazioni tra le parti.